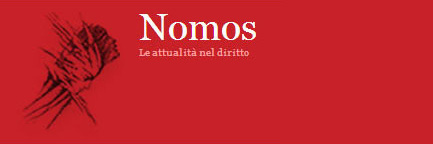La storia della giustizia costituzionale in Italia è già stata scritta più volte e da tempo[1], e sicuramente lo sarà ancora: a ondate si avverte infatti il bisogno di fare il punto su ciò che essa ha rappresentato e rappresenta per il complessivo sviluppo della vita delle istituzioni e dell’intero ordinamento.
Avverto subito che qui non farò luogo all’ennesimo racconto e confesso subito di non credere che giovi porre mano al tentativo di stabilire periodizzazioni alquanto rigide degli sviluppi della giustizia che – eccezion fatta di alcuni fatti clamorosi, che ne hanno segnato momenti di svolta[2] – a me sembrano essersi avuti nel segno di una sostanziale continuità, di una lenta e progressiva maturazione i cui esiti mi sforzerò ora di rappresentare, pur se in modo largamente approssimativo e incompleto, fermando l’attenzione unicamente sui profili che ai miei occhi appaiono di particolare interesse.
In primo luogo, si tratta di stabilire da quale angolo visuale riguardare le esperienze della giustizia. Riprendo al riguardo una impostazione che figura in un mio studio recente[3], adottando quale punto privilegiato di osservazione quello offerto dalla teoria della Costituzione, o meglio da una certa teoria, d’ispirazione assiologico-sostanziale, nella quale da tempo mi riconosco. E, poiché la Costituzione di un ordinamento di tradizioni liberali è in nuce quella mirabilmente fissata nella formula dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789, se ne ha che l’essenza della giustizia costituzionale si coglie per il modo con cui essa si è posta e si pone davanti ai diritti fondamentali nel tentativo di preservarli avverso ogni forma d’incisione da parte dei privati o dei pubblici poteri. La stessa giurisprudenza in materia di organizzazione merita, a mia opinione, di essere riconsiderata da quest’angolo visuale, per la ricaduta cioè che può aversene a beneficio ovvero a carico dei diritti e della loro tutela alle condizioni oggettive di contesto. […]
Scarica il testo in formato PDF
Sommario: 1. La riconsiderazione delle esperienze di giustizia costituzionale dall’angolo visuale privilegiato dei diritti fondamentali e dei modi della loro tutela, lo spartiacque segnato dalla revisione costituzionale del Titolo V avutasi nel 2001, con la conseguente, corposa crescita dei giudizi in via principale e la “europeizzazione” della giurisprudenza discendente dalla previsione nel nuovo art. 117 del limite degli obblighi internazionali. – 2. L’uso flessibile e talora abnorme fatto dalla Corte dei canoni di giudizio e la sempre più marcata sottolineatura dell’“anima” politica della Corte stessa, di cui sono emblematica testimonianza i casi in cui si è fatto luogo alla manipolazione dei parametri di giudizio (in ispecie, le novità al riguardo registratesi al piano dei rapporti interordinamentali). – 3. La giurisprudenza in tema di organizzazione, con specifico riguardo a quella relativa ai rapporti tra Stato e Regioni, la sostanziale continuità dalla stessa esibita (tanto più singolare a fronte delle vistose novità di dettato introdotte dalla riscrittura del Titolo V operata nel 2001), le conferme del carattere marcatamente politico dei giudizi venute da alcune esperienze riguardanti le fonti governative. – 4. Una succinta notazione finale, in merito ai casi, non infrequenti, di anomala “sussidiarietà” dei ruoli istituzionali e ai rischi che essi comportano per la tenuta dello Stato costituzionale-