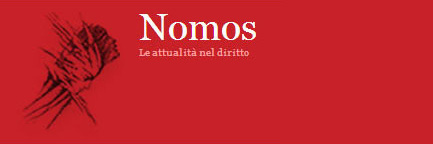Il processo di integrazione europea conduce ad un ridimensionamento dei parlamenti nazionali, e in questo modo del potere legislativo. Tale ridimensionamento avvantaggia non tanto il Parlamento Europeo, ma assai più i governi nazionali e il potere esecutivo, mentre l’incremento di competenze che il Parlamento Europeo ha invocato e ricevuto non è sufficiente a compensare questa perdita di importanza. Anche a livello europeo il Parlamento resta debole, persino in confronto ai parlamenti nazionali. Una migliore attribuzione di competenze potrebbe anche essere immaginabile, ma non eliminerebbe il deficit di legittimazione dell’UE.
In sintesi, è questa la tesi del presente contributo. Prima di entrare nel dettaglio, vorrei però precisare che la perdita di rilevanza non rappresenta una caratteristica specifica dei parlamenti. Quello che si ravvisa è soprattutto una generale tendenza alla deparlamentarizzazione: una tendenza che ha ragioni strutturali, che frustrano le speranze di un suo contenimento o di una sua eliminazione. Le ragioni strutturali derivano dalle mutate condizioni della politica statale, affetta da cambiamenti di due tipi: all’interno degli Stati essi sono causati dal passaggio dallo Stato liberale, che tutelava l’ordine precostituito, allo Stato sociale, finalizzato alla creazione di un assetto ordinato. Sul piano esterno, i cambiamenti si devono alla trasformazione degli Stati nazionali autonomi in Stati membri di organizzazioni internazionali, ed al trasferimento di sovranità dai primi a queste ultime. Dal momento che l’Unione Europea rappresenta un’organizzazione internazionale particolarmente integrata, l’erosione della funzione parlamentare si verifica in misura più forte che in altri contesti.
A livello internazionale, il processo decisionale di tipo deliberativo viene gradualmente sostituito da un procedimento di carattere negoziale. Sono soprattutto i governi a negoziare, mentre i parlamenti entrano in gioco solo per ratificare i risultati delle trattative. Il potere di influenza consentito dalla ratifica non è lo stesso che permette l’esercizio della potestà legislativa. Nel procedimento legislativo il Parlamento decide il contenuto della decisione, anche quando il progetto di legge proviene dal Governo, e questa non è solo una possibilità teorica, ma una realtà pratica. Raramente un disegno di legge di provenienza governativa diventa legge senza subire modifiche. Nella ratifica, invece, il contenuto della decisione è già stabilito. Il Parlamento può solo prendere o lasciare. Il rifiuto rappresenterebbe però un disconoscimento del Governo, che è sostenuto dalla maggioranza del Parlamento. Per questo, i costi politici di un “NO” risultano abitualmente troppo alti. I trattati europei hanno fallito solo laddove era previsto un referendum.
Lo spostamento dell’accento dalla deliberazione alla negoziazione non è determinato però soltanto da fattori esterni, in quanto esistono anche ragioni interne che lo determinano. Il motivo risiede nella modifica della statualità, che ha preso l’avvio già nel tardo XIX secolo e, malgrado alcune correzioni minime, non ha subito finora cambiamenti. Lo Stato non è più solo il garante di un ordine sociale preesistente e del quale si presuppone l’equità, ma sviluppa e modifica continuamente questo ordine, per adeguarsi a sfide mutevoli e a esigenze di giustizia. Esso porta oggi l’intera responsabilità per l’esistenza e il benessere della società. L’importanza maggiore è quella relativa al sostegno della crescita economica, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di ogni tipologia di rischio.
Molti di questi compiti non si possono più adempiere con l’ordine e l’obbligo, i tipici strumenti a disposizione dello Stato. In parte questo non è possibile, in parte non è consentito giuridicamente, in parte non è opportuno. Lo Stato è chiamato ad attuare i propri doveri di cooperazione con i soggetti privati, spesso quegli stessi soggetti che determinano i problemi che poi esigono un intervento dello Stato. I soggetti privati guadagnano così una posizione di veto che favorisce il passaggio ad una posizione negoziale. Se l’attuazione dei risultati del negoziato richiede una legge, non ci sono modi per aggirare il Parlamento. Ma questo si trova allora in una situazione simile a quella prevista dalla ratifica di trattati internazionali: non può determinare in alcun modo il contenuto della legge, ma solo confermarlo o respingerlo. Se le trattative avvengono in una modalità per la quale lo Stato rinuncia alla disciplina legislativa, mentre i soggetto privati che hanno causato il problema promettono una buona condotta, il Parlamento non entra nemmeno in gioco. […]
Scarica il testo completo in formato PDF
Di seguito si riporta il sommario del saggio: 1. Tendenze generali di deparlamentarizzazione 2. La situazione in Europa 2.1. Il trasferimento di sovranità dagli Stati membri all’UE 2.2. L’esercizio di competenze trasferite da parte dell‘UE 2.3. L’attuazione del diritto dell’Unione a livello nazionale 2.4. Compensazioni per la perdita di importanza dei parlamenti nazionali 3. Parlamentarizzazione della UE come compensazione?