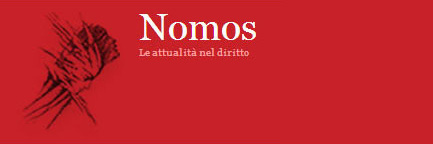Con la sentenza n. 33 del 2021, la Corte costituzionale torna a occuparsi della questione della cd. surrogazione di maternità, o, come forse sarebbe preferibile chiamarla, della gestazione per altri, dopo quattro anni dalla importante sentenza n. 272 del 2017. In quella occasione, a dire il vero, il giudice costituzionale non si era pronunciato su quanto disposto dalla legge n. 40 del 2004 che, come è noto, prevede, all’articolo 12, un divieto di ricorrere a tale pratica e una sanzione penale per coloro che «in qualsiasi forma, realizzino, organizzino o pubblicizzino la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità». Con la decisione in commento, invece, la Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale di tale articolo, dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), nella parte in cui tali disposizioni «non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”) del c.d. genitore d’intenzione non biologico». In particolare, secondo la prima sezione civile della Corte di Cassazione, tali previsioni si porrebbero in contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e agli articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, nonché all’ art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali disposizioni sarebbero violate sotto una molteplicità di profili: lesione del diritto all’identità personale del minore, da cui discende il suo diritto a rimanere nel proprio nucleo familiare; disparità di trattamento tra i minori nati attraverso la surrogazione di maternità e gli altri minori; irragionevolezza della previsione che consente di riconoscere il rapporto di genitorialità in capo al genitore biologico e non a quello “d’intenzione”. Le violazioni sarebbero evidenti alla luce del recente parere della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 aprile 2019 e di successive pronunce, cosicché sarebbe integrata anche la violazione indiretta dell’art. 117, comma primo, Cost., in relazione all’articolo 8 della Cedu. La Corte europea, infatti, sottolinea che nell’interesse dei minori nati attraverso la surrogazione, gli Stati devono riconoscere il legame di filiazione, potendo anche non trascrivere l’atto di nascita, ricorrendo, invece all’adozione, a condizione però che le modalità di tale adozione garantiscano l’effettività e la celerità della procedura. Secondo il giudice rimettente, al contrario, l’attuale diritto vivente in Italia, affermato dalle Sezioni Unite civili nel 2019, che prevede che si faccia ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari per riconoscere il legame con il genitore “d’intenzione”, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), non creerebbe un vero rapporto di filiazione. Come efficacemente sintetizzato dallo stesso giudice costituzionale «in sostanza, le questioni di legittimità che […] la Corte è chiamata a esaminare riguardano lo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata, vietata nell’ordinamento italiano dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004». Si tratta di una questione particolarmente delicata e complessa perché incide sulla relazione tra i bambini nati grazie a tale tecnica e il cosiddetto “genitore d’intenzione”, ovvero colui o colei che partecipa al processo procreativo esclusivamente attraverso un atto di volontà, l’intenzione, appunto, di formare una famiglia. La Corte risolve la questione con una sentenza di inammissibilità, che tuttavia può essere letta come una pronuncia di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, in quanto la motivazione si chiude con un monito al legislatore affinché intervenga al più presto «nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore». Ed è proprio questo profilo della decisione che merita di essere segnalato, perchè testimonia un significativo cambio di passo della giurisprudenza costituzionale su un tema riguardo al quale il giudice costituzionale sembra compiere un vero “balzo in avanti” rispetto al precedente del 2017.
Scarica il testo in formato PDF
SOMMARIO: 1. Il diritto vivente e lo status del minore nato grazie alla maternità surrogata. – 2. La sentenza n. 272 del 2017 e il principio di diritto formulato dalla Cassazione a sezioni nella sentenza n. 12193 del 2019. – 3. Il mutamento del contesto sovranazionale: dal parere sul caso Mennesson alla pronuncia della Corte europea D. contro Francia del 2020. – 4. La Corte e la necessità di un indifferibile intervento del legislatore per porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.