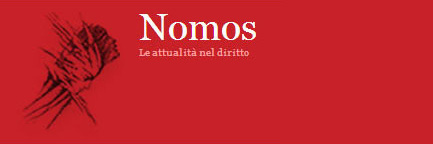Il sistema costituzionale italiano prevede e disciplina un’ampia gamma di consultazioni popolari che, in base all’ampiezza del corpo elettorale coinvolto, possono essere distinte in nazionali, regionali o locali. Mentre, con riferimento alle modalità di coinvolgimento del corpo elettorale, si hanno sia referendum obbligatori che eventuali. Nel primo caso, l’intervento del corpo elettorale costituisce un requisito necessario per il perfezionamento di un determinato atto (ad esempio, la fusione di più Regioni o la creazione di una nuova Regione); mentre nel secondo il coinvolgimento del corpo elettorale è demandato all’esistenza di un’esplicita richiesta avanzata da un determinato numero di soggetti a ciò legittimati (si pensi, ad esempio, al referendum abrogativo o costituzionale).1 In ambito nazionale si sono svolti tre tipi di consultazioni popolari: il referendum abrogativo, il referendum costituzionale e quelli istituzionali. Questi ultimi vengono istituiti con apposite norme di rango costituzionale e consistono nel demandare al voto del corpo elettorale una scelta di particolare valore istituzionale; il procedimento varia da caso a caso a seconda della disciplina contenuta nella legge costituzionale che li istituisce. Il primo di questi, attivato con il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 1946 demandò a un apposito referendum, che si tenne il 2 giugno 1946, la scelta circa la forma istituzionale dello Stato (Monarchia e Repubblica).
Furono le prime votazioni a suffragio universale della storia costituzionale italiana e i fautori della soluzione repubblicana prevalsero ottenendo 12.717.923 voti contro i 10.719.284 voti attribuiti alla monarchia. 2 Il secondo referendum istituzionale, convocato in seguito alla legge costituzionale n.2 del 1989, chiese agli elettori di decidere a favore o contro la trasformazione della Comunità economica europea nell’Unione europea: partecipò al voto l’80,6 % degli aventi diritto e a favore della trasformazione si pronunciò l’88% dei votanti. Il referendum costituzionale è, a sua volta, di tipo eventuale. Infatti, la legge costituzionale o di revisione costituzionale, se è approvata nella seconda votazione con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore senza che si possa richiedere alcun referendum. Qualora, invece, la legge consegua una maggioranza inferiore (ma comunque superiore alla maggioranza assoluta), può essere richiesto un referendum da parte di un quinto dei membri di ciascuna Camera, di cinque Consigli regionali o di cinquecentomila elettori. […]
Scarica il testo in formato PDF
Sommario: 1. I tipi di referendum previsti dall’ordinamento italiano. 2. La difficile convivenza tra referendum e democrazia rappresentativa. 3. Il quesito referendario. 4. La formulazione del quesito nei referendum costituzionali. 5. La formulazione del quesito nei referendum abrogativi.6.La riformulazione del quesito.