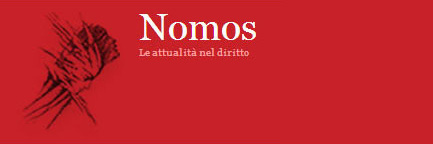Nel considerare Emilio Betti nella particolare prospettiva del titolo di questo studio, occorre in primo luogo premettere che le riflessioni che seguiranno desiderano essere uno spunto per ulteriori e più approfondite considerazioni, come meritano gli autori, i temi e le questioni lambite dalle prossime pagine.
Nell’intraprendere questo percorso, sembra fondamentale muovere dalla celebre prolusione con cui il 13 dicembre 1920 Giorgio Del Vecchio inaugurò il corso di filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma1. Emilio Betti, in una delle sue maggiori opere, vi si riferì espressamente, rivelando il forte impatto che ebbe anche su di lui: « È sempre degno di attenzione e di rispetto il tentativo di identificare i principi generali di diritto, intrapreso con una ben altrimenti consapevole serietà d’intenti e purità di cuore da chi ritiene di potersi rifare alle dottrine del “diritto naturale”, e di attingere ad un loro rinnovamento in senso moderno la riflessa coscienza storica dei problemi etici e politici da proporsi e dei valori della civiltà che oggi sono da tutelare»2.
Certamente non può tralasciarsi il dato per cui, nella stessa prefazione all’opera appena citata, Betti mostra di sgomberare il campo da qualsiasi malinteso, dichiarando di voler restare sul terreno fenomenologico della scienza, senza ascriversi a nessun particolare sistema filosofico, in quanto «la sua mèta è una teoria generale, pur se animata dalla fiducia nello spirito»3.
Eppure, proprio dopo aver elogiato il «tentativo» di Del Vecchio, Betti enuncia la sua nota dottrina dei principi generali, caratterizzati da un’eccedenza di contenuto assiologico, da virtualità e forza di espansione non già di indole logica e dogmatica, bensì valutativa, al punto che essi si pongono a fondamento dell’ordine giuridico, con una funzione genetica rispetto alle singole norme4. […]
Scarica il testo in formato PDF
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Emilio Betti filosofo. La critica al positivismo e al normativismo kelseniano. – 3. L’importanza dell’oggetto da interpretare. L’ascendenza vichiana. – 4. L’elemento valutativo assiologico è parte della scienza dell’interpretazione. – 5. Betti “costituzionalista”. Importanza e limiti della giurisprudenza. – 6. I valori etici e i principi. – 7. La continuità fra interpretazione logica, teleologica ed assiologica: la sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale. – 8. Conclusioni.