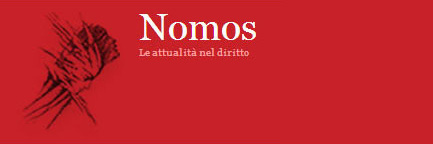Qualora si procedesse ad un’analisi diacronica e sistemica del ruolo rivestito dai Presidenti di Assemblea, sarebbe possibile notare come essi abbiano intrapreso, in particolar modo per quanto riguarda le ultime quattro legislature, un rinnovato processo evolutivo costellato da non poche difficoltà. Nell’intero arco di storia repubblicana, la carica di Presidente ha attraversato diversi momenti, riconducibili a tre fasi essenziali: innanzitutto quella relativa al periodo compreso tra il 1948 e il 1976, durante il quale l’elezione di talune personalità è stata strumentale al mantenimento degli equilibri delle coalizioni; la seconda, che va dal 1976 al 1993, allorquando ha preso avvio la convenzione costituzionale per cui la Presidenza della Camera è stata assegnata ad un rappresentante del principale partito di opposizione e la terza, inaugurata nel 1994 con l’avvento della Seconda Repubblica, durante la quale è emersa preponderante l’anima politica del Presidente stante l’incapacità della maggioranza di governare in Parlamento.
Questo è quanto emerge dalle pagine introduttive del volume “I Presidenti di Assemblea parlamentare”, dalle quali traspare come la carica di Presidente di Assemblea viva un’intrinseca contraddizione di fondo: svolgere tale compito rendendo possibile la convivenza delle sue due anime, quella istituzionale e quella politica, cercando di non soggiacere al binomio imparzialità/neutralità (quest’ultima intesa come intermediazione tra le forze politiche contrapposte) essendo i Presidenti chiamati ad espletare funzioni di mediazione e garanzia della legalità parlamentare.
Appare dunque evidente come il Presidente d’Assemblea sia da considerarsi come un Giano bifronte, in costante tensione tra i due modelli di riferimento: da un lato quello inglese, in cui lo Speaker della Camera dei Comuni è una figura imparziale con un peso politico quasi insignificante; dall’altro quello americano, in cui lo Speaker della Camera dei rappresentanti è politicamente esposto ed attivo, tanto da essere “spesso sovrapponibile al leader della maggioranza”. […]