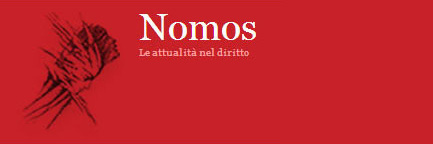Come si formano e come agiscono le istituzioni politiche? Si deve considerare la loro attività tutta racchiusa nelle norme che le creano oppure dipende da una prassi concreta, influenzata da fattori esterni ed interni, che via via ne configurano l’identità e le stesse funzioni? A queste domande, che per la verità dovrebbe sempre porsi lo storico e in particolare lo storico delle istituzioni politiche, risponde egregiamente il libro di Sandro Guerrieri del quale discutiamo questo pomeriggio: Un Parlamento oltre le nazioni. L’Assemblea Comune della CECA e le sfide dell’integrazione europea (1952-1958), Bologna, Il Mulino, 2017. Il tema, sinora più oggetto di indagini politologiche o giuridiche che non propriamente storicoistituzionali, è quello delle origini delle istituzioni europee (per meglio dire, dell’Europa unita) nell’immediato dopoguerra. Tema posto all’ordine del giorno sin dal 1948 (Guerrieri indica come data d’inizio quella del Congresso dell’Europa, svoltosi all’Aja il 7-10 maggio di quell’anno); ed imposto in qualche modo in tutti i Paesi dalla dolorosa riflessione a caldo che nacque sulla guerra mondiale. Come evitare che quella storia si ripetesse? Quali strategie adottare nel rapporto tra gli Stati? Con sensibilità e preoccupazioni diverse ma sempre acute, tutti i Paesi vincitori sentirono il bisogno di affrontare quella che da allora si potrebbe definire come la “questione europea”. E lo fecero con qualche efficacia, a giudicare dal fatto che a quella fase ha fatto seguito il più lungo periodo di pace che l’Europa continentale abbia conosciuto in tutta la sua plurisecolare storia. Un vivace movimento europeista, alla cui guida fu un grande intellettuale italiano, Altiero Spinelli, pose quel punto cruciale all’ordine del giorno. Il tema era, per dirla con una battuta, costituire un’Europa che fosse unita e democratica. Nessuno dei grandi leader del continente del dopoguerra, neppure i meno inclini all’europeismo come Charles De Gaulle, poté accantonare quell’interrogativo.
Tuttavia – come illustra benissimo questo libro – il dibattito fu lungo e difficile, il processo di sintesi molto problematico, il cammino per raggiungere il risultato caratterizzato da continui stop and go che talvolta fecero dubitare sull’esito finale. Del resto su quest’esito positivo, dopo il grande ottimismo europeista della fine del secolo scorso al quale abbiamo tutti partecipato, siamo oggi indotti a manifestare preoccupazioni serie, nelle ore segnate dalla crisi catalana. Nella quale io vedo immanente il rischio di un’Europa che, lungi dal trasformarsi in un sistema più democratico basato sulle autonomie, potrebbe facilmente degenerare nella pura e semplice rottura dell’unità faticosamente conquistata in mezzo secolo di sforzi comuni. […]