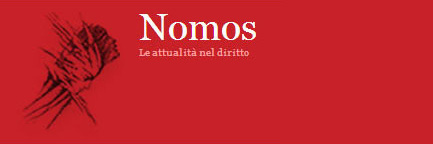Pubblicato ad un mese dall’inaspettata rielezione a di Giorgio Napolitano – evento senza precedenti nella storia della nostra Repubblica – il volume di Vincenzo Lippolis e Giulio M. Salerno si è proposto il valido compito di offrire una chiara ed esaustiva lettura del settennato di un Capo dello Stato che ha scritto una pagina importante della storia della Presidenza della Repubblica italiana, non fosse altro che per la straordinaria decisione delle forze politiche di riconfermarlo al Quirinale. In realtà già prima della sua rielezione, la presidenza di Napolitano aveva assunto caratteri molto forti e decisivi in determinati passaggi di crisi della nostra democrazia, con accentuate sfumature leaderistiche, tanto da far parlare la dottrina e la politica di presidenzialismo o di semipresidenzialismo all’italiana. Ed è proprio su questo nodo che il saggio di Lippolis e Salerno può tornare più utile: innanzitutto per compiere un’ordinata ed esauriente analisi dell’operato di Napolitano nel corso del suo primo settennato, ma soprattutto torna utile per svolgere alcune considerazioni circa le paventate e millantate trasformazioni istituzionali che – tacitamente e, quindi, a Costituzione invariata – avrebbero influito sulla forma di governo. Vero è che in molti aspetti il settennato di Napolitano si è rivelato sui generis ed ha assunto i caratteri propri di un sistema a tendenza monocratica presidenziale, ma a ben vedere non è intervenuta nessuna forzatura o rottura della forma di governo parlamentare, che rimane tal qual era nel suo disegno formale dei costituenti del ’48. L’opinione frettolosa e voyeuristica di chi decanta un nuovo regime presidenziale manca della riflessione sulla plasticità del nostro impianto istituzionale che può modellarsi alle varie contingenze storico-politiche grazie all’elasticità del dettato costituzionale che, a sua volta, rende estremamente adattabile la costituzione materiale. E questo in particolar modo si verifica per le norme sul Presidente della Repubblica, appositamente pensata per far sì che il Capo dello Stato possa espandere e contrarre i propri poteri per svolgere, da un lato, la schmittiana funzione di “custode della Costituzione”, rappresentante dell’unità nazionale e dei supremi valori da questa espressi nella carta fondamentale, e per colmare, dall’altro, vuoti di potere creati da istituzioni delegittimate e indebolite, assumendo così il ruolo di “reggitore della crisi” di cui parlava Carlo Esposito nel 1960.
Lo scopo del saggio si rivela quindi quello di scoraggiare qualsiasi “deriva presidenziale”, già peraltro decantate da più voci: così il Corriera della Sera ha ospitato la penna di Sartori, che ha parlato di presidenzialismo parlamentare (editoriale Cor.Sera 26 febbraio 2012), mentre la Repubblica ha pubblicato, ad una settimana dalla rielezione di Napolitano, un editoriale di Ilvo Diamanti che annunciava il presidenzialismo preterintenzionale. Questione di discrasia metodologica tra giuristi e scienziati della politica? Sembra di no, poiché anche ad una rapida ricognizione superficiale, in dottrina si incontrano la vecchia tesi di Barile del 1958, recentemente ripresa da Omar Chessa, i quali parlano di partecipazione del Presidente alla formazione dell’indirizzo politico. Al di là delle più disparate teorie classificatorie delle forme di governo imperniate su dualismo/monismo (Luciani), su collaborazione/subordinazione (Vergottini) o sul sistema partitico (Elia), i due Autori accolgono la teoria di derivazione mortatiana, ampiamente accettata nel mondo accademico, che per la distinzione fra le varie tipologie usa la discriminante della «direzione politica dello Stato», in altre parole bisogna tener conto dell’organo che effettivamente determina l’indirizzo politico (Lanchester). E sta proprio qui la soluzione alessandrina del nodo gordiano: solo nel caso in cui il Presidente riuscisse ad imporre un proprio indirizzo politico potrebbe parlarsi di presidenzialismo di fatto – e la locuzione “di fatto” si fa necessaria dal momento che nessuna riforma è intervenuta a modificare il testo costituzionale. […]