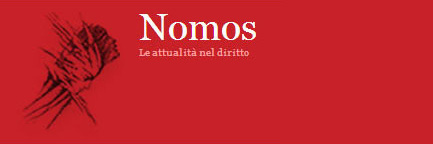In una questione di grande rilievo sostanziale, l’ordinanza qui commentata fa applicazione di una tecnica decisoria che era stata già sperimentata in due occasioni precedenti e si colloca nella stagione di particolare effervescenza processuale che si vive da alcuni anni a Palazzo della Consulta. La tecnica consiste nell’uso di un’ordinanza per rinviare di qualche tempo, a data fissa, la decisione definitiva di una questione, contestualmente anticipando, almeno in parte, i contenuti di questa decisione, tendenzialmente nel senso dell’accoglimento, e invitando il Parlamento a intervenire, entro il termine del rinvio, sulla situazione normativa in esame e sui problemi costituzionali posti da essa. Gli stessi Presidenti della Corte costituzionale ne hanno parlato come di una incostituzionalità «prospettata». È davvero il segno di un cambiamento durevole nel modo di governare e decidere le questioni di legittimità costituzionale? All’apparire di questa nuova figura, c’era stato chi aveva dubitato che potesse andare al di là del primo, particolarissimo caso, in occasione del quale era stata elaborata, e consolidarsi come un vero e proprio modulo suscettibile di generalizzazione o, comunque, di impiego in un più ampio novero di fattispecie. Ora siamo alla terza applicazione in tre anni, ma pare ancora prematuro formulare consuntivi e, per la verità, anche prognosi. La tecnica decisoria – ammesso che se ne possa parlare in questi termini, almeno come ipotesi di lavoro – è ancora in via di assestamento. Come sempre, il suo successo, o meno, dipenderà da numerosi fattori, anche storici e istituzionali, mutevoli e non agevolmente prevedibili. Nondimeno, è possibile osservare la traiettoria compiuta sino a qui e ragionare, se non proprio sulle sue future evoluzioni, almeno sui segnali da tenere d’occhio all’orizzonte. È questa la prospettiva adottata nel presente commento. Salvo alcuni cenni indispensabili all’economia del ragionamento, si lascia da parte il pur rilevantissimo tema sostanziale dell’ordinanza n. 97 del 2021, ampiamente squadernato dalla dottrina anche alla vigilia della decisione e subito all’indomani di essa. Neppure si intende dare istruzioni ai giudici comuni su cosa fare in attesa della decisione definitiva della Corte costituzionale, o ragionare sugli sviluppi possibili a seconda delle reazioni del Parlamento. Saranno accantonati anche temi processuali interessanti, come l’imponente dispiegamento di amici curiae. L’attenzione si focalizzerà, invece, sulla tecnica decisoria impiegata e, da questo punto di vista, la decisione commentata sarà paragonata ai precedenti immediati e messa a confronto con alcuni temi del fitto dibattito sviluppatosi in proposito. Dopo la prima applicazione, la tendenza della Corte è andata nel senso di allentare il reticolo di prescrizioni che accompagnano l’invito al legislatore a provvedere entro il termine fissato: un passo in direzione di una collaborazione più aperta e di un maggiore rispetto del ruolo del Parlamento. Tuttavia, ciò non risolve le ambiguità insite nel metodo prescelto: anzi, in un certo senso, può accentuarle. Del resto, esse riflettono problemi di fondo, la cui difficoltà è acuita da dinamiche esterne, seppure naturalmente collegate, agli istituti di giustizia costituzionale.
Scarica il testo in formato PDF
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La tecnica decisoria e i suoi precedenti. – 3. Il dibattito. – 4. Quattro osservazioni conclusive (più due).